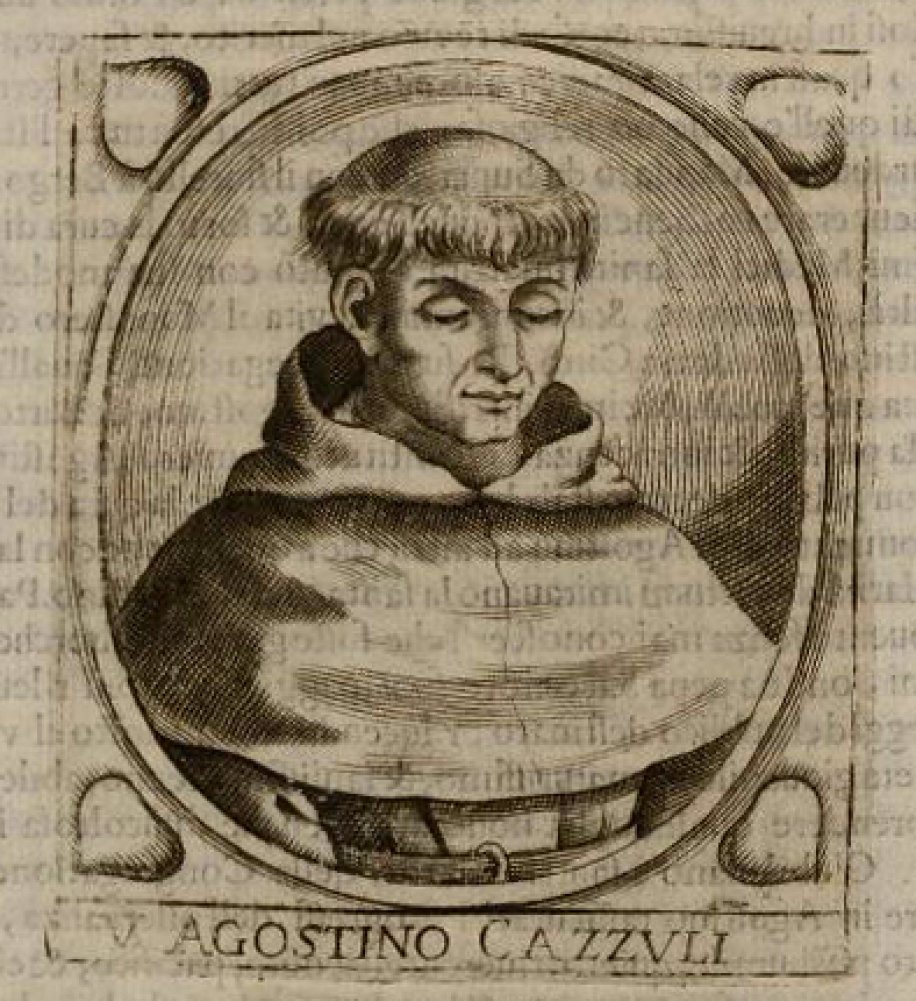COMMENTO |
Nel 1442 la comunità del Convento bergamasco entra a far parte dell'Osservanza di Lombardia, e così cambia il modo di gestire anche il convento e l’edificio chiesa. La Città, da poco passata sotto il dominio veneziano, promuove attraverso il Consiglio generale la riforma del convento di Sant’Agostino introducendovi la regola dell’osservanza sotto la guida dei fratelli Cazzulli. Peculiare della congregazione osservante è la diffusione de culto di san Nicola da Tolentino, un frate agostiniano vissuto nel XIII secolo, canonizzato nel 1446. Invocato per la protezione di tutte le anime del Purgatorio, era festeggiato il 10 settembre. Nella chiesa di Bergamo, nella seconda metà del XV secolo, venne intitolato a questo santo l'altare presente nell'abside laterale destro, e in seguito l'abside stesso venne decorato con un ciclo di affreschi che raccontavano la vita del santo. La vivacità di questo culto portò anche alla fondazione di una confraternita, nel 1502.
L’altare maggiore della chiesa viene inoltre arricchito nel 1449 di una grande ancona che così ci descrive il Verani nel 1766: Occupava direi un terzo del Coro grandiosa, antica Macchina adorna di varie statue di legno colorite in parte, e in parte adorate di molto pregio a suo tempo, ma che al presente nulla aveva di rimarchevole, se non la veneranda antichità di ben trecent’anni; ergevasi essa su soda base raccomandata a quattro massiccie colonne co’ suoi capitelli, ed occupando tutto lo sfondo del Coro, giungeva col capo a toccarne il volto medesimo, ed assorbendo con la sua ampiezza quella poca di luce tramandata dall’unica finestra laterale, e la voce insieme corale, rendeva il Coro medesimo oscuro alla vista, ed ingrato all’orecchio, per una tal qual sordità di voci, e di suono, che necessariamente n’usciva.
All'arrivo dei Frati osservanti la Città è governata da quelle stesse famiglie aristocratiche che saranno poi autorizzate a costruire proprie cappelle particolari per deporvi i propri defunti, e non più semplicemente collocare le sepolture vicino agli altari preesistenti. La possibilità di avere una propria cappella particolare nella chiesa di Sant'Agostino (così come in altre chiese cittadine) è espressione del prestigio di cui godono queste famiglie. Peculiare delle nuove cappelle è la collocazione in esse di un altare dedicato a un santo titolare, santo scelto già dal testatore quando ne dispone la costruzione: santo che esprime quindi la devozione particolare del singolo e della sua famiglia. La presenza del’ altare è connessa alla celebrazione di messe di suffragio, in occasione degli anniversari, messe celebrate grazie a rendite a ciò destinate dal testatore (legati di messe). E’ una condizione nuova che viene richiesta a quelle famiglie per la concessione della facoltà di costruire la propria cappella. Diverso era stato il caso della prima cappella Zanchi (la quarta da destra), costruita prima del 1444, inizialmente solo per ospitare tombe, e in cui solo in un secondo momento (XVI secolo) viene collocato l’altare di Sant'Orsola.
Le prime cappelle realizzate secondo queste nuove regole sono le tre cappelle a destra dell’ingresso principale: furono costruite a pianta quadrata con volta a crociera con costoloni (così almeno nella sola cappella conservatasi) e arco verso navata a sesto acuto. Questa tipologia è ben visibile ancora nella terza cappella. Attualmente le prime due cappelle presentano pianta a emiciclo, perché trasformate nel 1680, ma hanno mantenuto l’arco a sesto acuto, traccia della struttura originaria. L’arco tamponato del lato ovest della terza cappella porta a ipotizzare che fosse comunicante con la seconda cappella e che questa avesse la medesima profondità. Nel caso della prima cappella, un’altra traccia della struttura originaria è rimasta nella muratura accostata a destra della facciata, terminante con un pilastro in pietre ben lavorate, con alla sommità lo stemma della famiglia Roncalli, con data 1471 (oggi cancellata) (solo nel Novecento è stata realizzata un apertura, come testimoniato dalle foto storiche). Questa muratura è simmetrica a quella che, allineata alla facciata, immette mediante portale a tutto sesto nel chiostro minore, ma completamente differente per tecnica costruttiva: la muratura a sinistra della facciata è in blocchi in arenaria simili a quelli della facciata e in fase, la muratura di destra invece si accosta è costituita da tessitura irregolare in pietrame di diverse dimensioni simile alla muratura esterna della suddetta terza cappella. Sono indizi che portano a ritenere che anche le due cappelle scomparse avessero le stesse caratteristiche architettoniche della terza cappella, che si è conservata pressoché intatta.
Il diritto di costruzione della cappella di Sant'Antonio, la prima a destra dell’ingresso, viene concesso nel 1469 dal capitolo di Sant'Agostino ad Antonio Roncalli. Tra le varie indicazioni relative all’arredo della cappella (che verrà ultimata nel 1471), c’è anche quella di recuperare le pietre risultanti dallo sfondamento della muratura perimetrale della chiesa trecentesca per la realizzazione della stessa cappella. La cappella contigua (la seconda a destra), dedicata ai santi Pietro e Paolo, venne realizzata dal convento stesso grazie ad un lascito testamentario di Accorsino Carrara del 1495, dopo la rinuncia per mancanza di fondi da parte di Antonio Boschi, che aveva ottenuto la licenza di costruzione già nel 1469. Dai documenti emerge che questa cappella è posteriore a quella dell’Annunciata (la terza a destra) e a quella di Sant'Antonio, e che - per volontà del testatore - venne realizzata simile a quest’ultima.
Tutti i caratteri architettonici superstiti indicano una notevole omogeneità nell’aspetto delle cappelle, esito di una accurata sorveglianza dei frati agostiniani per l’aspetto estetico della chiesa: anche nei documenti con cui si autorizzano le famiglie nobili alla costruzione di queste cappelle vi sono precise indicazioni perché siano mantenuti sempre gli stessi canoni estetici, sebbene realizzate una indipendentemente dall’altra, nell’arco di almeno 30 anni.
Nel corso degli ultimi decenni del Quattrocento e dell’inizio del Cinquecento sette cappelle gentilizie verranno costruite, lungo entrambi i lati della chiesa, sia al di qua che al di là del podiolo, segno questo che si sta perdendo la nozione della funzione liturgica di questa struttura, l’iconostasi, cioè la separazione tra area destinata ai laici ed area destinata ai religiosi. Anche questa è una novità nella cultura religiosa portata dai frati osservanti.
Per raggiungere quell’obiettivo di uniformità stilistica, a partire dalla fine del Quattrocento il regista degli interventi effettuati sia nella chiesa (il tetto terminato tra il 1444 e il 1476 e le cappelle aggiunte), sia nei corpi intorno ad essa, è il frate Jacopo Filippo Foresti che, incaricato dal padre priore, si occuperà sia degli aspetti formali-architettonici che dei rapporti contrattuali con le maestranze e con i pittori decoratori: tra i magistri menzionati nei contratti stipulati dal Foresti emergono in particolare i muratori Bernardino da Serina e Defendo da Fontanella ed i picapietra (scalpellini, scultori) Giovanni Fantoni di Valtesse e Bonadio Grigis di Ranica.
L’attività del Foresti non si limita alla sola chiesa ma all’intero complesso conventuale : In questi anni (1501) far fare otto volti del claustro dalla parte d’oriente, far fare 13 colonne di pietra per il chiostro uniformi a quelle che sono sotto le celle del dormitorio.
Sotto la "direzione" del Foresti vengono realizzate le prime tre cappelle sul lato sinistro dell’ingresso, la sesta sullo stesso lato, della famiglia Albricci, e la cappella di Accorsino Carrara, quella degli Zonca e quella di Rossetto Rota, rispettivamente la seconda, la quinta e la settima sul lato destro. Della cappella del Rota, intitolata a San Giovanni Battista, e poi sostituita da una struttura a emiciclo, i documenti ci dicono che era bassa, di pietre adorate e con quattro colonne e capitelli, il che fa pensare che avesse anch’essa una pianta quadrata e fosse coperta da volta a crociera.
Le prime tre cappelle sul lato sinistro differiscono da quelle sul lato destro perché ottenute costruendo dei semplici emicicli che sfondano il muro perimetrale, non potendosi allargare come le precedenti per la presenza del chiostro minore accostato alla chiesa. La prima di queste, dedicata a Ognissanti o a San Marco, è la cappella della famiglia Passi (costruita tra il 1495 e il 1506), la seconda, dedicata ai Santi Sebastiano e Rocco, fu fatta costruire dalla famiglia Vertova (nel 1486), demolendo così il tratto di parete con l’affresco dell’Albero della Scienza; la terza, dedicata a San Girolamo, venne fatta costruire dai Signori di Comenduno (nel 1489). Quest’ultima venne indicata dal Foresti come modello per la realizzazione della cappella dei Passi e di quella di Accorsino Carrara (la seconda sul lato destro, costruita nel 1495 ed ora demolita).
Nel luglio 1501 il Foresti stipula il contratto per la costruzione della cappella Zonca, intitolata a Santa Caterina: questa cappella è la quinta sul lato destro, subito al di là del podiolo. Sempre al di là del podiolo, la sesta cappella a sinistra venne costruita in forza del lascito testamentario di Bartolomeo Albrici del 1493, ed in seguito, nel 1501, il Foresti diede incarico al pittore Francesco Jorcii di decorare la cappella già costruita; questa cappella venne intitolata a Santa Maria e Santa Caterina. |
|---|